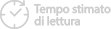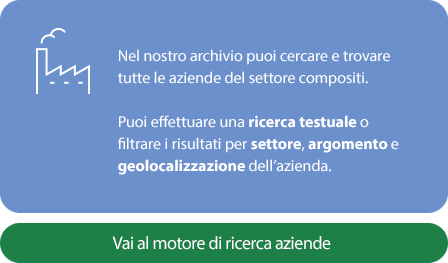di NICOLA CATENARO
Dalla valorizzazione della comunità scientifica italiana all’esplorazione delle potenzialità dei biocompositi, passando per il ruolo cruciale della ricerca multidisciplinare: il nuovo presidente di AIMAT (Associazione italiana d'ingegneria dei materiali), il professor Gianluca Cicala (docente di Scienza e tecnologia dei materiali e vice direttore del DICAR dell’Università di Catania), delinea la sua visione per un futuro in cui ingegneria dei materiali, sostenibilità e trasferimento tecnologico si intrecciano per rispondere alle sfide dell’industria e della società.
Professor Cicala, quali sono le sue priorità come nuovo presidente di AIMAT?
«Sicuramente tra le priorità le principali saranno quelle di potenziare la comunicazione dell’associazione AIMAT e, in seconda battuta, potenziare l’utilizzo di alcune risorse già presenti in AIMAT mirate alla diffusione della conoscenza sull’ingegneria dei materiali anche attraverso il ricorso ad iniziative congiunte di ricerca. Sono, infatti, convinto che la comunità AIMAT abbia una base di conoscenza e dati che, se ulteriormente razionalizzata e sistematizzata, possa essere di grande impatto per l’avanzamento tecnico in diversi settori».
Quali sono le prospettive più interessanti nel campo della ricerca sui nuovi materiali?
«Esistono diverse prospettive che rivestono notevole interesse come testimoniato dall’ultimo congresso nazionale AIMAT tenutosi ad Ischia dal 31 agosto al 3 settembre. Al congresso hanno partecipato 220 iscritti con circa 300 comunicazioni orali e poster. Il convegno si è aperto con un interessante plenaria del professor Teodoro Valente, past-presidente AIMAT e attuale presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sul tema del futuro dell’esplorazione spaziale seguito da un intervento del professor Edoardo Bemporad, componente del direttivo AIMAT e attuale direttore del CNR-ICPB, sul tema della ricerca dei materiali in Europa. Cito questi due interventi perché entrambi hanno messo in evidenza, a mio avviso, come la complessità della ricerca sui materiali richieda ormai approcci multidisciplinari con competenze verticali e orizzontali nonché con una massa critica di ricercatori interagenti. In questo senso, ad esempio, la necessità di sviluppare nuovi materiali multifunzionali, ovvero dotati di più proprietà specifiche che consentano al materiale di svolgere più funzioni appare una sfida strategica. In questo ambito possiamo annoverare i materiali con capacità di ripararsi (self healing), o di generare o immagazzinare energia, di rilevare parametri quale la temperatura o lo stato tensionale etc. Ma il convegno ha dimostrato come anche i materiali e le applicazioni più tradizionali possono beneficiare di approcci innovativi sviluppati in altri contesti. Per esempio, la professoressa Valeria Daniele ha illustrato come la conservazione di manufatti storici in legno può, oggi, essere affrontata mediante l’utilizzo di nanomateriali a base di idrossido di magnesio che, in altri ambiti, trova utilizzo come materiale antibatterico, ritardante di fiamme etc. Non da ultimo, diverse presentazioni hanno illustrato l’importanza dello sviluppo di nuovi materiali a basso impatto ambientale. Questo approccio comporta un radicale cambio di paradigma nel modo di concepire il materiale con una progettazione che includa le fasi di produzione, uso, riciclo e riuso. L’ultima fase, per alcuni materiali, può essere particolarmente sfidante. Si pensi ad esempio a materiali per batterie che siano non solo in grado di immagazzinare grandi quantità di energia ma, anche a fine vita, di essere facilmente riciclabili e riutilizzabili nello stesso ciclo produttivo. Questo aspetto, per esempio per i materiali basati sull’utilizzo di terre rare, diventa fondamentale nella prospettiva di carenze di risorse sul mercato globale. Sempre in tale ottica, anche lo sviluppo dei biocompositi offre spunti interessanti».
Quali sono, secondo lei, le principali opportunità che i biocompositi offrono per la transizione verso un’economia più sostenibile e circolare?
«Se per materiali biocompositi intendiamo materiali che siano prodotti da fonti rinnovabili e che, a fine vita, siano o integralmente riutilizzabili o perfettamente riciclabili nell’ambiente senza arrecare danno stiamo, chiaramente, parlando del Santo Graal dei materiali. In quest’ottica, e limitatamente ad una classe di materiali compositi, ho presentato dei risultati di alcune ricerche che il mio gruppo Polimeri e Compositi sta conducendo. In questo caso la chiave di lettura sta nell’individuare nella chimica dei termoindurenti a base epossidica la soluzione al problema della riciclabilità. Infatti, i termoindurenti, sono una volta reticolati, stabili e non degradabili. Alcune nostre ricerche hanno dimostrato che una selezione accurata dei gruppi chimici da inserire nella struttura rende il materiale degradabile in condizioni controllate in modo da ottenere materiali a struttura semplice direttamente riutilizzabili nello stesso ciclo produttivo. Ho parlato di Santo Graal perché, seppur i risultati ottenuti siano promettenti, in questo caso l’ottenimento di prodotti integralmente da fonte rinnovabile appare ancora difficile perché non sempre il materiale naturale presenta le caratteristiche termomeccaniche adatte limitandone l’applicabilità».
Quali settori industriali (aerospazio, automotive, edilizia, biomedicale, ecc.) stanno mostrando il maggiore interesse e potenziale nell’adozione di biocompositi?
«Potenzialmente tutti i settori che ha menzionato sono interessati ai biocompositi. Tuttavia, è bene chiarire che, in alcuni ambiti, esistono limiti tecnici e normativi difficili da superare. Ad esempio, nel settore aerospazio i requisiti termomeccanici e di rispetto di stringenti normative rende difficile immaginare l’utilizzo di biocompositi in strutture primarie. Esistono però applicazioni specifiche che potrebbero beneficiare delle peculiarità dei biocompositi. Solo per citare un esempio, in strutture aerospaziali pensate per operare in atmosfera la possibilità di avere materiali con degradazione controllata potrebbe essere utile per il problema dei detriti in atmosfera. Se poi guardiamo ad alte applicazioni come gli interni per l’automotive, che da anni utilizza composti rinforzati in fibra naturale, l’uso dei biocompositi è sicuramente affermato ed estendibile ad altri settori. Nel settore dell’edilizia, se per biocompositi intendiamo materiali derivati direttamente da sostanze naturali o processi naturali, c’è sicuramente grande fermento e i cataloghi delle maggiori ditte del settore riportano già prodotti affermati».
Quali sono le principali sfide tecniche ancora da superare per rendere i biocompositi competitivi con i materiali tradizionali?
«A mio avviso esistono ancora diversi limiti legati, per lo più, ad alcune specifiche di tali materiali. Se guardiamo alle matrici derivata da fonte naturale e rinnovabile, come quella derivate da oli vegetali, un grosso problema può essere l’effettiva disponibilità di quantità massive e la stabilità del prodotto stesso. Per anni, infatti, l’industria è stata abituata ad utilizzare prodotti derivati da raffineria con cicli produttivi svincolati da condizioni ambientali. Se i prodotti di partenza derivano da fonte vegetale, la capacità di scalare la produzione è, a volte, in competizione con il settore alimentare o, in altri casi, limitata dalla disponibilità effettiva delle colture. Tanto è vero che nei recenti bandi di finanziamento della BBI (https://www.cbe.europa.eu) si è richiesto di sviluppare progetti di ricerca che non utilizzassero prodotti del ciclo alimentare. Per fare un esempio, se si derivano matrici per termoindurenti dalla soia si impatta su un prodotto alimentare che è alla base di diversi sistemi alimentari e, di sicuro, non è un bene alterare il prezzo e la disponibilità di questa tipologia di materiale. Inoltre, in molti casi esistono vincoli tecnici legati ad esempio alle proprietà termomeccaniche dei materiali naturali, che limitano la possibilità di rimpiazzare i materiali da raffineria con materiali naturali. In quest’ottica esistono però segnali interessanti, cito l’esempio dell’epicloridina verde (https://epinitychem.com) che può essere utilizzata, in combinata con bisfenoli naturali, per la produzione di resine epossidiche al cento per cento verdi e con proprietà controllate».
In che modo AIMAT può favorire il trasferimento delle innovazioni dai laboratori di ricerca alle applicazioni industriali concrete?
«AIMAT è una realtà complessa che vede al suo interno più di 200 ricercatori di tutte le università italiane. Questo comporta un insieme complesso e completo di competenze nell’ambito dei saperi legati all’ingegneria dei materiali. Già oggi i nostri ricercatori collaborano strettamente con le aziende nazionali ed internazionali assistendole nello sviluppo dei materiali e delle tecnologie connesse. AIMAT, che per statuto deve promuovere sia l’insegnamento della scienza e ingegneria dei materiali sia la collaborazione tra il mondo della ricerca e delle associazioni, può sicuramente fare da cassa di risonanza per le iniziative e le innovazioni realizzate dai suoi associati».
Quali competenze ritiene fondamentali per formare la nuova generazione di ingegneri e ricercatori?
«Su questo punto ci tengo a ricordare che la past-president, professoressa MariaPia Pedeferri, e il direttivo uscente hanno svolto un lavoro egregio e puntuale sia nel mappare la distribuzione degli insegnamenti su Scienza e Tecnologia dei Materiali erogati dai docenti di IMAT-01/A sia, e direi principalmente, nell’interagire con il Ministero per l’Università (MUR), per la definizione della declaratoria del settore e per l’istituzione della classe di laurea “Scienza e ingegneria dei materiali” (LM-53). Questo importante lavoro consentirà al nuovo direttivo di avere una base di dati solida per valutare le azioni future. Tra le proposte per il futuro, ci sarà sicuramente il consolidamento delle competenze di base con, al contempo, l’aggiornamento delle competenze trasversali quali, ad esempio, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ricerca e sviluppo dei materiali. In quest’ottica mi fa piacere richiamare la Scuola Estiva AIMAT tenutasi nel 2024 dal titolo “Intelligenza Materiale: dagli Smart Materials all’Intelligenza Artificiale” organizzata dai professori Pedeferri e Tirillò. Nell’ambito di tale scuola è emerso chiaramente il grande contributo che l’intelligenza artificiale sta avendo ed avrà nella scienza ed ingegneria dei materiali. Quindi, posso affermare che l’AIMAT è molto attiva sia nel consolidamento della didattica di base sia nello sviluppo di didattica innovativa».
-

-
25 settembre 2025